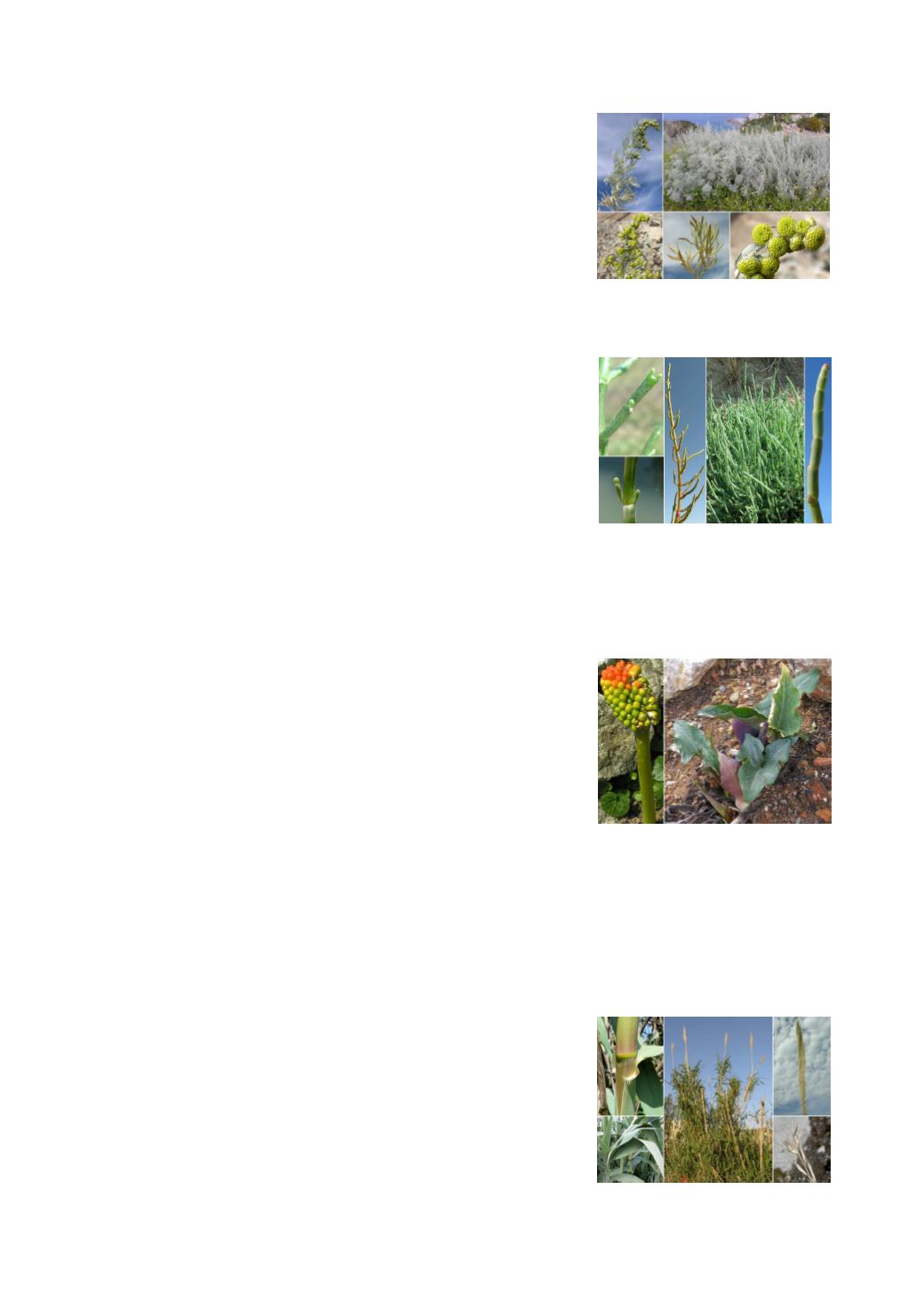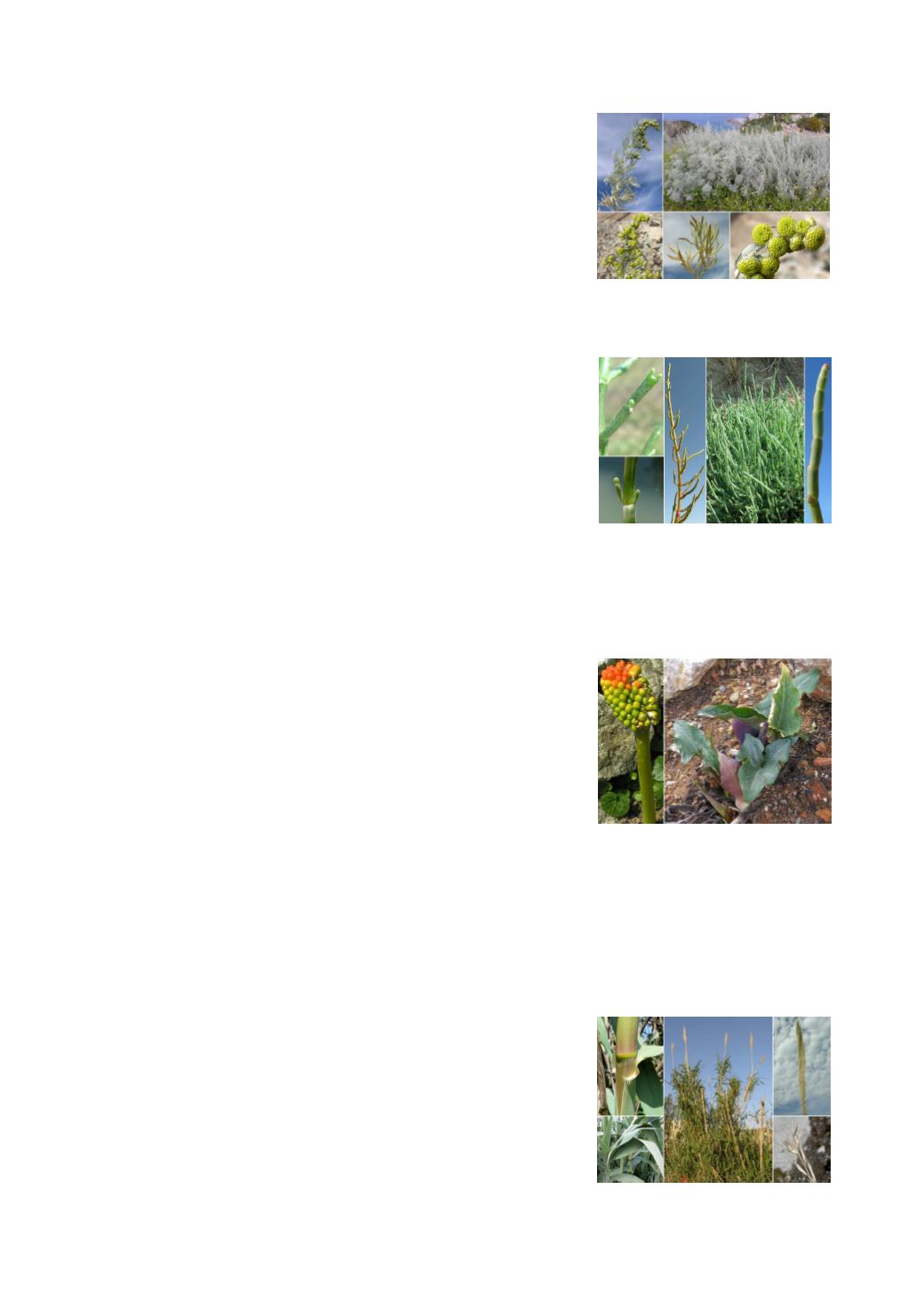
2
38
tufacee, su vecchi muri, nelle garighe mediterranee, a volte anche in ambienti
piuttosto disturbati, dal livello del mare a 1000 m circa, con optimum nella
fascia mediterranea. La specie era utilizzata in campo medico, come
antiparassitario, contro i disturbi gastrici, e come stimolante per l'appetito.
Ancora oggi è usata per aromatizzare liquori. Come le altre specie congeneri,
contiene il tossico thujone, per cui la commercializzazione dell'assenzio era
vietata in Francia sino a poco tempo fa. Il nome generico era già in uso presso i
Greci antichi ma è di etimologia incerta: potrebbe riferirsi alla dea Artemide
(Diana) o alla regina Artemisia, moglie di Mausolo, re di Caria; quello
specifico si riferisce al portamento alto-arbustivo della pianta. Forma
biologica: nanofanerofita/ fanerofita cespugliosa. Periodo di fioritura: aprile-giugno.
Arthrocnemum macrostachyum
(Moric.) K. Koch
La salicornia glauca è una specie alofila a distribuzione mediterraneo-
macaronesica presente lungo quasi tutte le coste italiane (manca in Liguria e in
Molise e non è stata più ritrovata in tempi recenti nelle Marche e in Abruzzo).
Sull'Isola dell'Asinara non è molto diffusa; è presente lungo le coste
meridionali, (Spalmadori, Cala S. Andrea e Punta Salippi). Cresce su suoli
fangosi in siti litorali con salinità molto più elevata di quella marina; l'habitat
tipico è rappresentato dai suoli adiacenti alle zone umide salmastre (stagni,
paludi, lagune) occupando anche aree soggette a temporanea sommersione da
parte di acque salse. Forma delle praterie più o meno rade chiamate
comunemente salicornieti, associandosi con altre comuni Chenopodiaceae
alofite e con specie di altre famiglie, tutte con adattamenti alle alte
concentrazioni saline; i salicornieti, insieme ai canneti di aree interessate da un minore accumulo di salinità, sono i più
importanti siti di nidificazione e rifugio de
ll'avifauna delle zone umide costiere. Il nome generico deriva dal greco
'arthron' (giuntura, articolazione) e 'kneme' (gamba) in riferim
ento ai fusti articolati; il nome specifico deriva anch'esso
dal greco e significa 'a spighe grosse'. Forma biologica: camefita succulenta. Periodo di fioritura: agosto-settembre.
Arum pictum
L. f. subsp.
pictum
Il gigaro sardo-corso è una specie paleoendemica a distribuzione
stenomediterraneo-occidentale diffusa nelle Isole Baleari, in Corsica, in
Sardegna e nell'Isola di Montecristo. Sull'Isola dell'Asinara è abbastanza
diffusa. Cresce nelle macchie, nelle siepi e nei cespuglieti, in prati umidi e al
borgo di ruscelli, su suoli freschi almeno in inverno e primavera, dal livello del
mare a 1000 m circa, con optimum nella fascia mediterranea. Il meccanismo di
impollinazione è molto particolare: i fiori, unisessuali, sono addensati su una
struttura colonnare chiamata spadice, circondata da una grande brattea
petaloide (detta spata), che permette l'entrata degli insetti attraverso delle setole
ripiegate sovrastanti i fiori maschili, attirandoli sia con l'odore che con un
notevole aumento della temperatura all'interno della spata stessa. Le setole
successivamente si alzano chiudendo l'entrata e imprigionando gli insetti; le antere maturano e scaricano su di essi il
polline, dopodiché le setole si ripi
egano nuovamente lasciando uscire gli insetti carichi di polline. Tutta la pianta
contiene sostanze
fortemente tossiche ma termolabili; il contatto cutaneo può provocare irritazioni, l'ingestione di parti
fresche, soprattutto dei frutti, avvelenamenti anche mortali; il rizoma è ricco di amido e un tempo veniva utilizzato
previa cottura persino per l'ali
mentazione umana. Il nome generico, di etimologia incerta, era già in uso presso i Greci
e i Romani; quello specifico, che significa 'colorato' si riferisce al colore rosso-
violaceo dell'infiorescenza. Forma
biologica: geofita rizomatosa. Periodo di fioritura: ottobre-novembre.
Arundo donax
L.
La canna domestica è una specie probabilmente originaria dall'Asia
occidentale, introdotta e oggi diffusa in tutta l'area mediterranea, presente in
quasi tutte le regioni d'Italia (mai segnalata in Valle d'Aosta). Sull'Isola
dell'Asinara cresce presso Cala Reale, Trabuccato e Elighe Mannu ove è
utilizzata anche come frangivento e siepe divisoria. Cresce su terreni umidi e
freschi lungo gli argini di fiumi, torrenti e fossati, in aree sabbiose ripariali,
lungo i margini di campi coltivati, spesso in ambienti antropizzati, dal livello
del mare ai 900 m circa. Viene utilizzata per creare siepi frangivento e per
costruire palizzate e graticciati, tettoie rustiche, recinzioni, stuoie, canne da
pesca, bastoni da passeggio, cestini, etc. Fornisce un'ottima cellulosa per carta.
I fusti sono comunemente usati anche come tutori in orticoltura e nelle vigne.
La pianta contiene silice che la rende par
ticolarmente tenace e resistente. Serviva anche per fabbricare frecce e