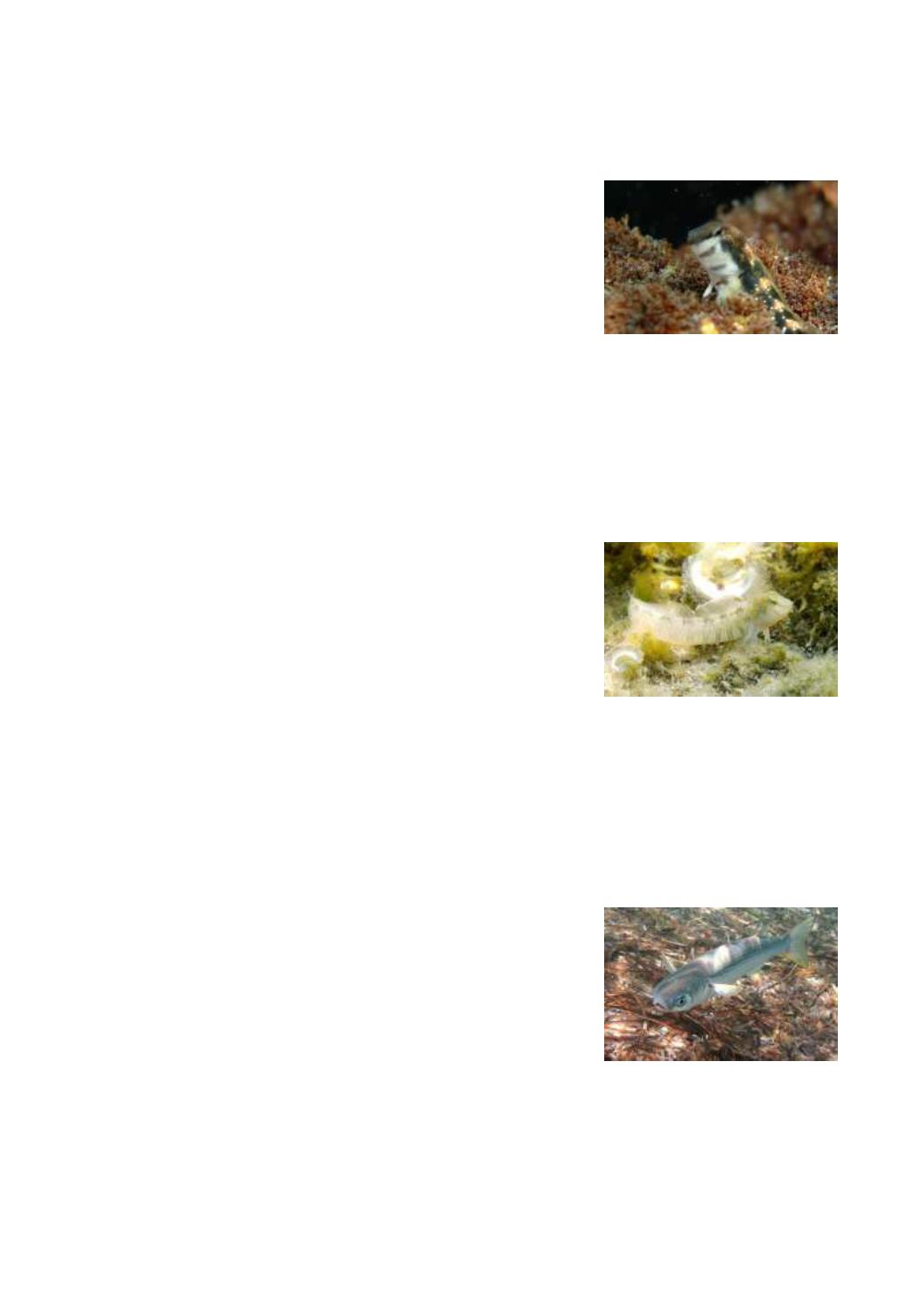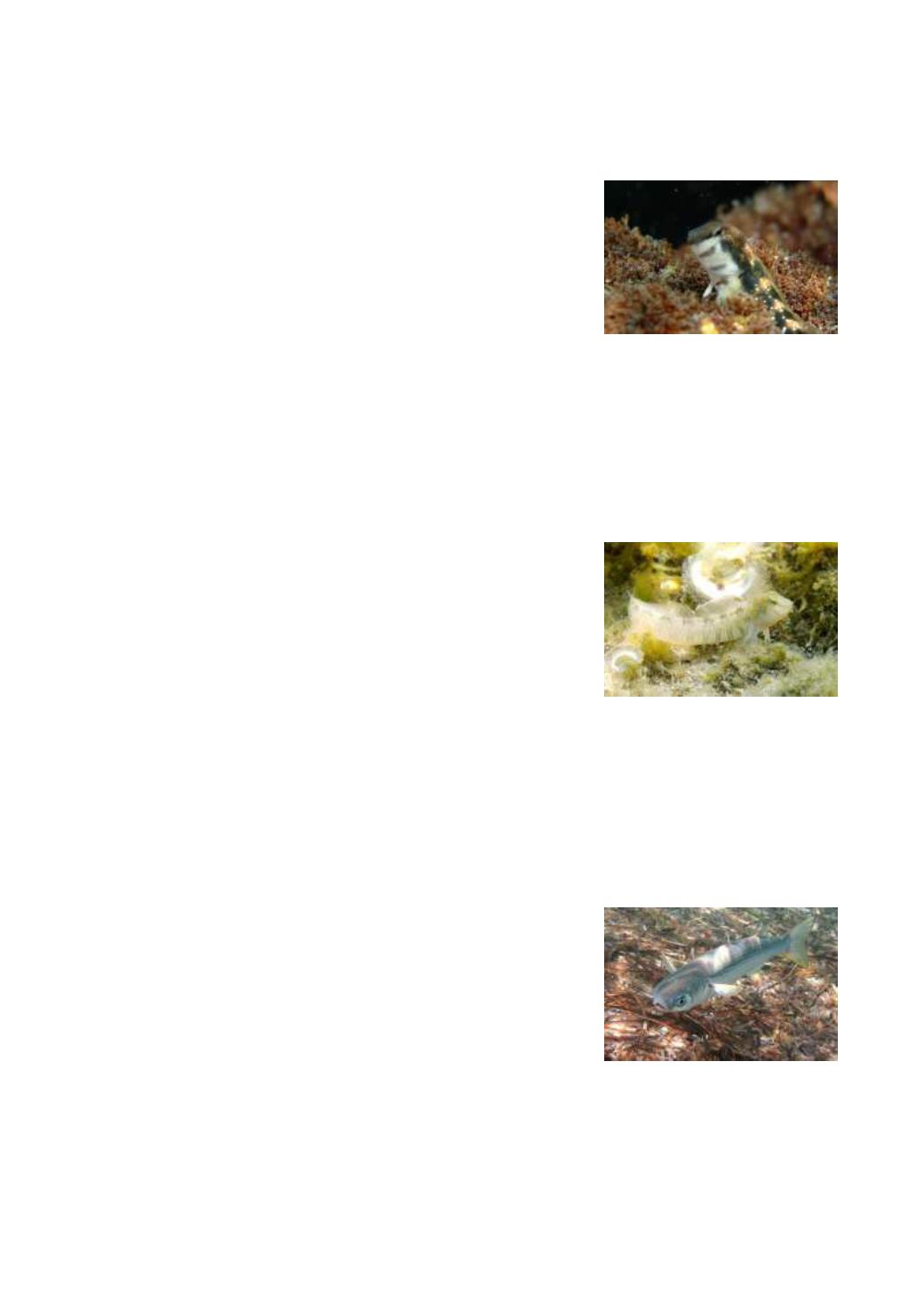
68
Microlipophrys adriaticus
(Steindachner & Kolombatovic, 1883)
BAVOSA ADRIATICA
Dimensioni e caratteri distintivi
Tra le bavose più piccole, non supera i 6 cm
di lunghezza. Il capo è privo di tentacoli. I maschi in periodo riproduttivo
possono presentare il capo nero con le guance gialle (ma senza i puntini tipici
invece della bavosa guance gialle,
L. canevae
).
Distribuzione
È presente lungo
le coste rocciose dell’Adriatico, mentre risulta più rara procedendo verso sud e
negli altri mari italiani. In Alto Adriatico la si ritrova anche nei substrati duri
artificiali (moli foranei, dighe), mentre in Laguna di Venezia occupa solo le aree
a maggior salinità, nei pressi delle bocche porto, ove trovi substrato idoneo.
Habitat preferenziali
Si incontra in zone rocciose superficiali riparate, ricche
di alghe, in particolare sulle rocce quasi verticali ed esposte al sole.
Biologia
riproduttiva
Si riproduce tra aprile e luglio. I maschi difendono piccole cavità nella roccia dalle quali sporgono solo
con la testa nella classica livrea riproduttiva (testa nera con guance gialle). La femmina sceglie il compagno, entra nel
nido, depone le uova sulla superficie interna (grazie a filamenti adesivi), e poi lascia le cure interamente al maschio, che
ventila e protegge l’ovatura sino alla schiusa.
Alimentazione
Si nutre piccoli invertebrati marini che cerca tra le alghe.
Autoctonia e norme di tutela
Specie autoctona.
Microlipophrys dalmatinus
(Steindachner & Kolombatovic, 1883)
BAVOSA DALMATINA
Dimensioni e caratteri distintivi
Tra le bavose più piccole, non supera i 5 cm
di lunghezza. Il capo è privo di tentacoli. I maschi in periodo riproduttivo
possono presentare il capo nero con le guance gialle (ma senza i puntini tipici
invece della bavosa guance gialle,
L. canevae
).
Distribuzione
È diffusa in tutte
le coste rocciose dell’Italia peninsulare e insulare, più scarsa al sud. In Alto
Adriatico è presente nei substrati duri artificiali (moli foranei, dighe) e nelle
coste rocciose del Triestino, della Slovenia e della Croazia; in Laguna di
Venezia occupa le aree a maggior salinità, nei pressi delle bocche porto.
Habitat preferenziali
Si incontra in zone rocciose superficiali riparate, ricche
di alghe, in particolare sulle rocce con poca pendenza e molta esposizione al
sole.
Biologia riproduttiva
Si riproduce tra aprile e luglio. I maschi difendono piccole cavità nella roccia dalle quali
sporgono solo con la testa nella classica livrea riproduttiva (testa nera con guance gialle). La femmina sceglie il
compagno, entra nel nido, depone le uova sulla superficie interna (grazie a filamenti adesivi), e poi lascia le cure
interamente al maschio, che ventila e protegge l’ovatura sino alla schiusa.
Alimentazione
Si nutre piccoli invertebrati
marini che cerca tra le alghe.
Autoctonia e norme di tutela
Specie autoctona.
Mugil cephalus
Linnaeus, 1758
CEFALO COMUNE
Dimensioni e caratteri distintivi
Può raggiungere una lunghezza totale pari a
70 cm ed un peso massimo di 5 kg; è il cefalo che raggiunge le dimensioni
maggiori fra quelli presenti nel Mediterraneo. La testa è tozza e lateralmente al
capo le palpebre adipose (spesse membrane trasparenti a copertura dell’occhio)
sono molto sviluppate ed evidenti, incise solo all’altezza della pupilla.
Distribuzione
La specie è ben presente in tutte le zone costiere dell’Italia
insulare e peninsulare; dopo lo sviluppo embrionale, gli avannotti si spostano in
acque salmastre e dolci per la fase di accrescimento.
Habitat preferenziali
Specie eurialina che vive sia in mare, in prossimità della superficie, sia nelle
lagune, negli stagni costieri, nelle zone estuariali e nei tratti bassi dei fiumi,
prediligendo substrati fangosi o sabbiosi e ricchi di vegetazione. Tollera bene anche ambienti portuali o fortemente
inquinati e si vedono spesso nuotare gruppi di 10-15 individui a pelo d’acqua.
Biologia riproduttiva
La maturità
sessuale viene raggiunta nelle acque interne al 2° anno di età dai maschi ed al 3° dalle femmine, seguita dal ritorno al
mare. Il periodo riproduttivo va da luglio a settembre. L’accoppiamento avviene in gruppi composti solitamente da 1
femmina e 3-5 maschi; le uova fecondate, direttamente nella colonna d’acqua, vengono poi trasportate dalle correnti in
quanto provviste di una goccia oleosa che ne facilita il galleggiamento (uova pelagiche).
Alimentazione
Gli avannotti si
cibano di zooplancton e, occasionalmente, di invertebrati bentonici. Da adulti la dieta è costituita da materiale vegetale
e da detrito organico, in particolare si nutre dei microrganismi in esso presenti, oltre che da invertebrati bentonici.