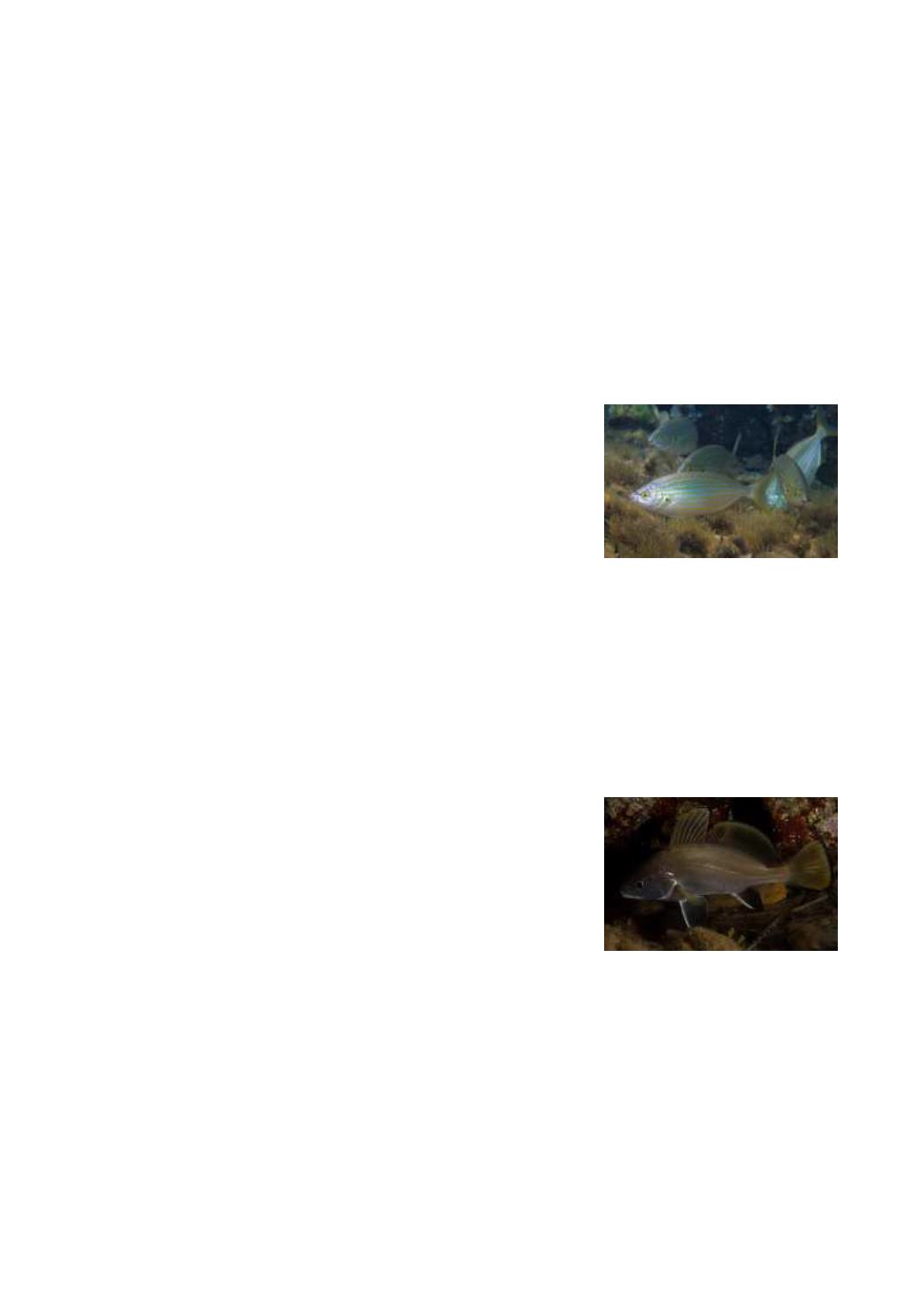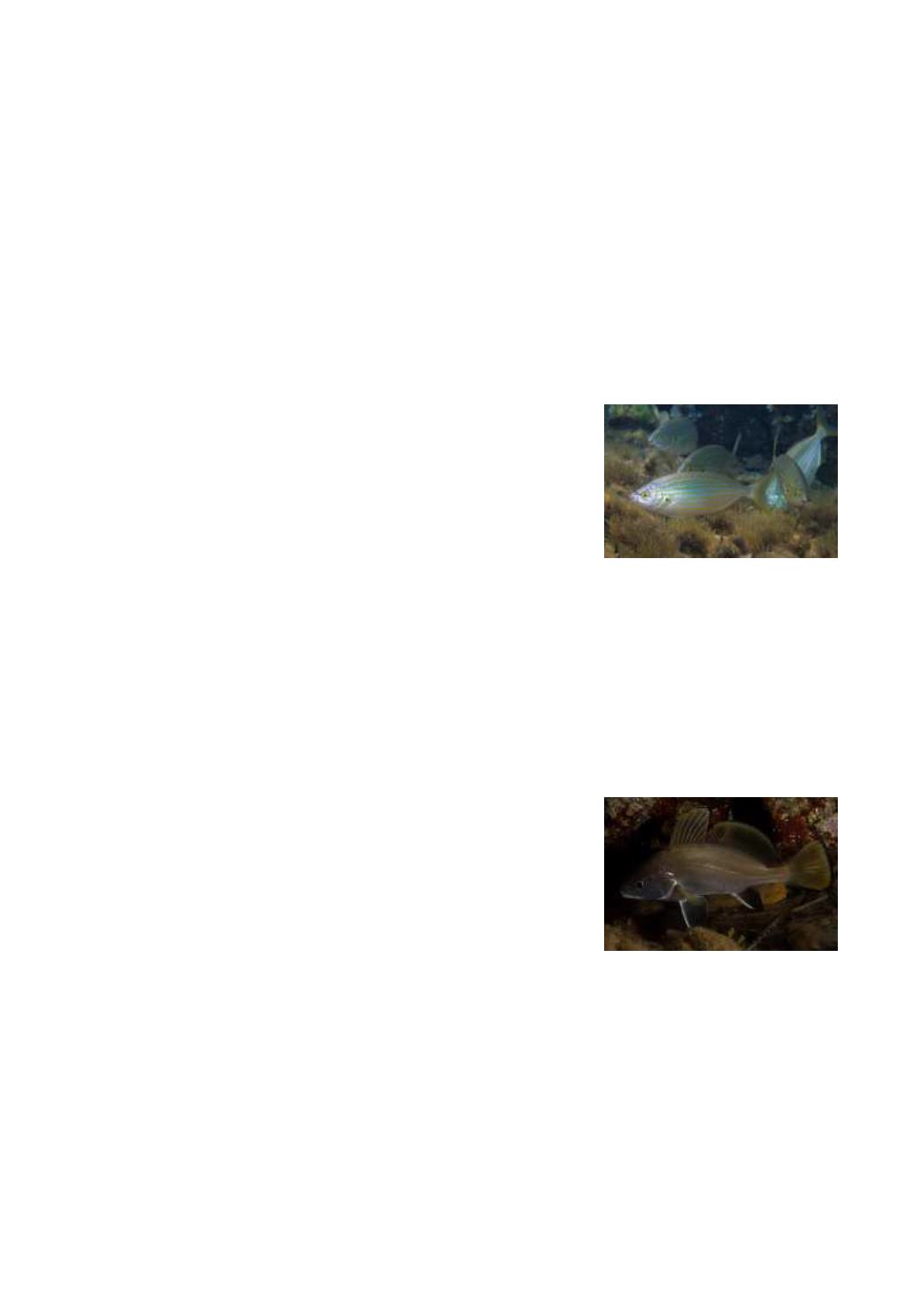
79
numerosissimi (specie gregaria) nella colonna d’acqua, lontano dal fondo, solitamente in mare aperto ma, talvolta, più
sotto costa. Di notte nuota in acque superficiali (5-35 m) ed è attirata dalla luce, mentre di giorno può muoversi a
profondità maggiori (10-55 m). La sua curiosità nei confronti delle fonti luminose è stata da sempre usata per la pesca di
questa specie, e lo è ancora oggi, grazie ad apposite lampade montate sulle barche e all’uso delle grandi reti a
circuizione, in grado di accerchiare il banco e chiudersi sotto di esso. In estate si avvicina alle coste mentre in inverno
rimane più al largo.
Biologia riproduttiva
Al momento della riproduzione si raccoglie in banchi molto numerosi, a
profondità comprese tra i 20 e i 30 metri, e gli individui maturi liberano i propri gameti (uova e spermi) in acqua. La
fecondazione è esterna e le uova, dotate di una piccola goccia oleosa che ne facilita il galleggiamento, vengono
trasportate dalle correnti (uova pelagiche). Raggiunge la maturità sessuale nel primo anno di età e ogni femmina può
produrre un numero altissimo di uova (50-60 mila).
Alimentazione
Si nutre principalmente di piccoli crostacei presenti
nel plancton, ma anche di altri piccoli invertebrati planctonici.
Autoctonia e norme di tutela
Specie autoctona.
Sarpa salpa
(Linnaeus, 1758)
SALPA
Dimensioni e caratteri distintivi
Pesce di medie dimensioni, può raggiungere i
50 cm di lunghezza, più comune attorno ai 30 cm.
Distribuzione
Diffusa in
tutto il Mediterraneo, presente in Adriatico e nelle zone più prossime al mare
della Laguna di Venezia (moli foranei, dighe sommerse, ecc.).
Habitat
preferenziali
Vive nelle zone costiere frequentando le scogliere rocciose e le
praterie di fanerogame (piante marine come la posidonia e la zostera) entro i 15-
20 m di profondità. Nuota in banchi numerosi, anche in pochi metri d’acqua, sia
in fase giovanile che adulta. Gli adulti a volte si allontanano dalla costa
nuotando in banchi in acque libere.
Biologia riproduttiva
È una specie
ermafrodita proterandrica, come l’orata e la mormora, ovvero uno stesso
individuo, nell’arco della vita, matura e si riproduce prima come maschio e poi come femmina. L’inversione sessuale
avviene a taglie prossime ai 25 cm. Le uova vengono rilasciate nella colonna d’acqua (pelagiche). Si riproduce nei mesi
di settembre e ottobre.
Alimentazione
La salpa è tra le poche specie di pesci erbivori presenti in Mediterraneo (assieme
al pesce pappagallo (
Sparisoma cretense
) e al pesce coniglio ((
Siganus luridus
) di più recente insediazione e non
presenti in Adriatico). Si ciba essenzialmente di alghe verdi (in particolare del genere
Ulva
, la lattuga di mare,
abbondante in acque salmastre) e di frammenti di fanerogame marine come la posidonia, la zostera e la cimodocea.
Autoctonia e norme di tutela
Specie autoctona.
Sciaena umbra
Linnaeus, 1758
CORVINA
Dimensioni e caratteri distintivi
Pesce di medie dimensioni, può raggiungere i
70 cm ma è più comune a taglie comprese tra i 35-45 cm. I giovani, che possono
entrare in acque salmastre, hanno colorazione aranciata e le pinne appaiono, in
proporzione, molto grandi e perfettamente sviluppate. Negli adulti le pinne
dorsale e caudale sono giallastre con bordatura nera, mentre le pinne pelviche e
la pinna anale sono interamente nere con il primo raggio spinoso evidente e
bianco.
Distribuzione
Specie costiera presente in tutto il Mediterraneo, meno
comune in Adriatico, presenza occasionale in Laguna di Venezia.
Habitat
preferenziali
Vive su fondali rocciosi e praterie di fanerogame (vere e proprie
piante marine come la posidonia), sino a 20-25 m di profondità, potendo tuttavia
spingersi a profondità maggiori (-180 m). Predilige gli ambienti rocciosi ricchi di cavità, grotte ed anfratti in cui rimane
nascosta di giorno, anche in gruppi di 15-20 individui, mentre di notte è più attiva ed esce dai rifugi nuotando in piccoli
gruppi in cerca di cibo. Frequenta gli ambienti salmastri e lagunari soprattutto in fase giovanile. A volte è possibile
sentire le corvine ancora prima di vederle! Questi pesci, infatti, sono in grado di produrre suoni secchi, simili allo
sbattere di sassi, utilizzando la vescica natatoria (vedi glossario) come cassa di risonanza; è possibile sentire questo tipo
di schiocchi se si sorprende un gruppo di individui fuori tana e sembra, quindi, che abbiano funzione di allarme. Dal
momento che sono solo i maschi a produrre suoni, si suppone, inoltre, che possano avere un qualche ruolo per la
riproduzione, ma non ci sono informazioni dettagliate a riguardo.
Biologia riproduttiva
La corvina si riproduce in
primavera inoltrata e prosegue in estate. La fecondazione è esterna. Le uova sono sferiche, pelagiche e dotate di goccia
oleosa che ne facilita il galleggiamento. Vengono trasportate dalla corrente per 3-4 giorni al termine dei quali avviene la
schiusa. Anche le larve sono inizialmente pelagiche, successivamente si verifica il ritorno all’ambiente bentonico, di
fondo.
Alimentazione
Si nutre principalmente di notte quando esce dal proprio rifugio e caccia piccoli pesci, molluschi
e crostacei.
Autoctonia e norme di tutela
Specie autoctona.