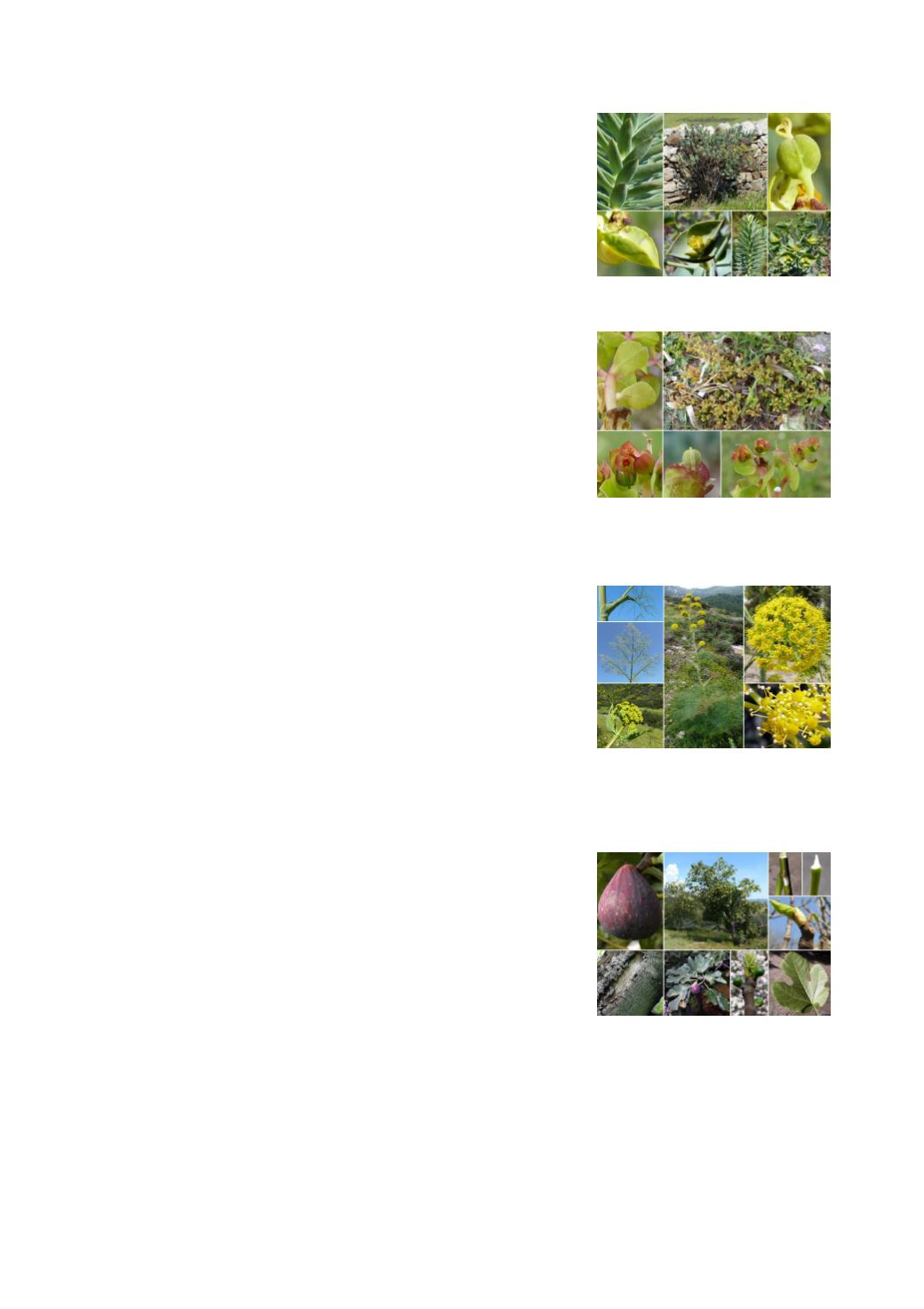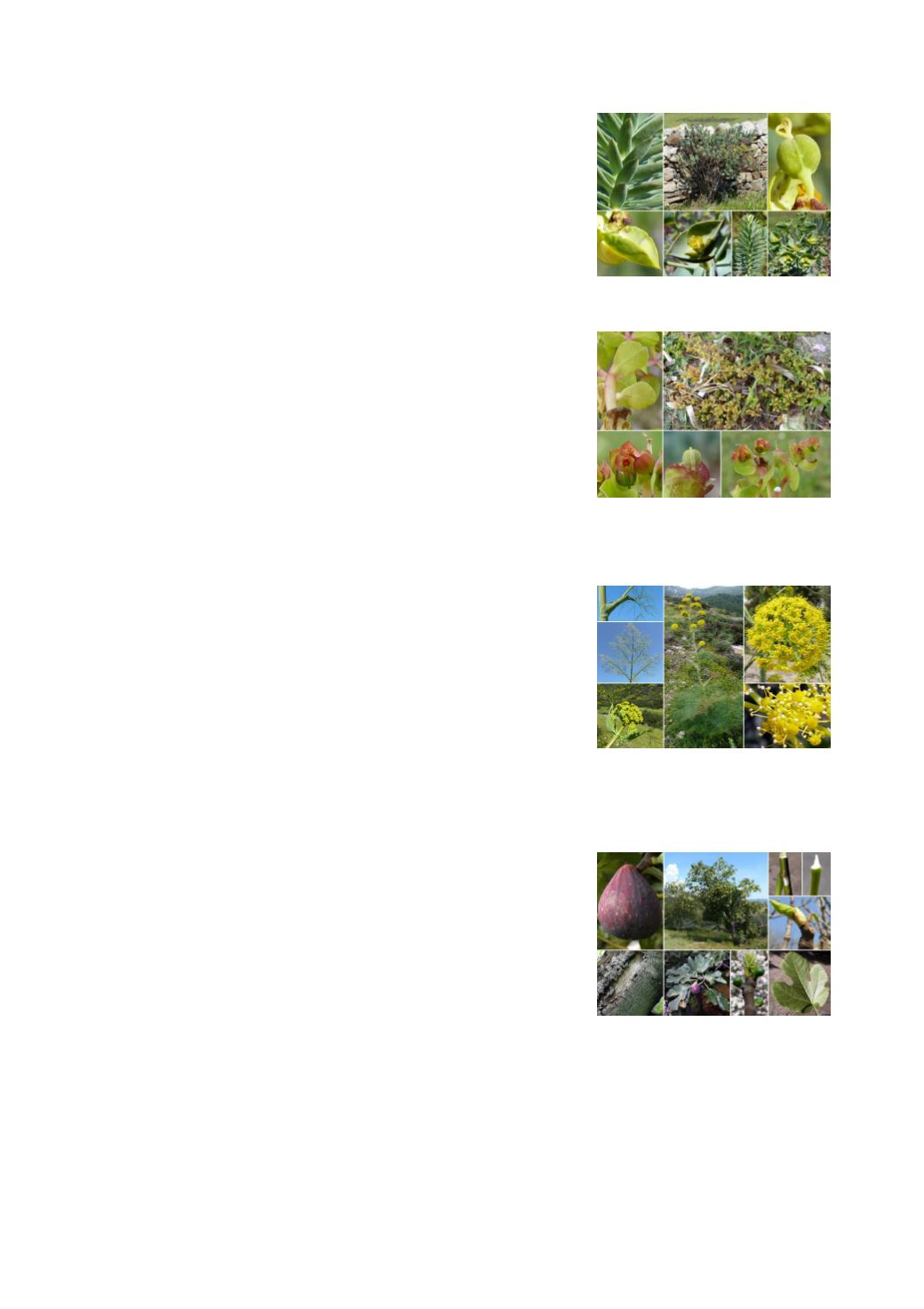
2
81
aridi presso al mare, su rupi e scogliere, nella fascia mediterranea. Il latice è
velenoso: molto irritante per le mucose, può scatenare reazioni fotoallergiche.
Il nome generico deriva da Euforbo, medico del Re Giuba II di Mauritania (I
sec. a.C. - I sec. d.C.), che secondo Plinio scoprì l'euforbia e le sue proprietà; il
nome specifico, di significato incerto, deriva dal greco 'píthos' (botte). Forma
biologica: camefita suffruticosa. Periodo di fioritura: aprile-luglio.
Euphorbia pterococca
Brot.
L'euforbia con frutto alato è una pianta annua a distribuzione estesa dalla
porzione occidentale della regione mediterranea alla Macaronesia, presente in
quasi tutte le regioni dell'Italia centrale, meridionale e insulare (manca soltanto
nelle Marche, in Umbria e in Basilicata). Sull'Isola dell'Asinara è diffusa; ad
esempio presso Cala d'Oliva e Case Bianche (Bocchieri, 1988). Cresce in
incolti aridi, a volte anche lungo le strade, su suoli prevalentemente sabbiosi,
aridi d'estate, dal livello del mare a 500 m circa. Il latice è velenoso: molto
irritante per le mucose, può scatenare reazioni fotoallergiche. Il nome generico
deriva da Euforbo, medico del Re Giuba II di Mauritania (I sec. a.C. - I sec.
d.C.), che secondo Plinio scoprì l'euforbia e le sue proprietà; il nome specifico
in greco significa 'a cocche alate', in riferimento alle due ali ondulate presenti su ciascuna delle tre logg
e della capsula.
Forma biologica: terofita scaposa. Periodo di fioritura: aprile-maggio.
Ferula communis
L.
La ferula comune è una specie mediterranea presente in tutte le regioni
dell'Italia centro-meridionale (ove è più frequente), in Liguria, Lombardia,
Emilia-Romagna e Veneto. Sull'Isola dell'Asinara è presente ovunque, ad
esempio presso Elighe Mannu, Rio di Baddi Longa (da Elighe Mannu a Cala
Arena), Castellaccio, Cala Arena, Punta Fregata, Punta Maestra Serre, Zonca e
Cala Tappo (Bocchieri, 1988). Cresce negli incolti, in siti sassosi e assolati, nei
pascoli, ai bordi delle strade, al di sotto della fascia montana. Il fusto secco,
tenace e leggero è utilizzato per costruire sedie, sgabelli e altri oggetti
d'artigianato. La pianta è tossica: l'ingestione delle parti aeree provoca nei
bovini e negli ovini il cosidetto 'mal della ferola', grave intossicazione con
manifestazioni emorragiche che possono portare alla morte. I
l nome generico in latino significa 'canna', ma anche
'bacchetta, sferza' in quanto il fusto secco serviva per le punizioni corporali di scolari indisciplinati. Forma biologica:
emicriptofita scaposa. Periodo di fioritura: maggio-giugno.
Ficus carica
L.
Il fico è una specie di origine mediterranea estesa all'Asia occidentale, da noi
di introduzione precolombiana come altre specie legnose di interesse
economico (
Castanea
,
Celtis
,
Juglans
). È presente in tutta Italia, spontaneo o
coltivato, dal livello del mare agli 800 m, anche come piccolo arbusto su muri
ed in stazioni rupestri soleggiate. Sull'Isola dell'Asinara è presente
comunemente nei cortili delle abitazioni; alcuni esempi si possono osservare a
Fornelli, Tumbarino, Campu Perdu, Trabuccato, Cala d'Oliva; un esemplare
maestoso si trova accanto a una vecchia costruzione nell'ampio altipiano
situato a sud-est di Case Bianche (Bocchieri, 1988). Le infruttescenze sono
costituite da numerosi acheni (i veri frutti) dentro un'urna (il sicono ingrossato)
esternamente verde o violetta; nel fico selvatico maturano in tre epoche diverse: 1) i profichi (o fichi fiori),
sviluppantisi dalle gemme dell'anno precedente e maturanti a giugno-
luglio, con fiori maschili e femminili gallicoli
brevistili; 2) i forniti (o mammoni o fichi propriamente detti), sviluppantisi nell'annata e maturanti in agosto-
settembre
con fiori sia maschili (pochi) che fiori femminili brevistili e longistili; 3) i c
ratiri (o mamme o fichi tardivi), che si
formano in autunno e svernano maturando nella primavera seguente, con soli fiori femminili gallicoli. La formazione e
maturazione dei frutti del fico selvatico (o caprifico) è possibile solo se avviene la fecondazio
ne da parte di un insetto,
la
Blastophaga psenes
. Nei cratiri in autunno le femmine depongono le uova entro gli ovari brevistili, trasformandoli
in galle, da cui alla fine dell'aprile successivo si sviluppa la prima generazione; le femmine fecondate escono
e
penetrano nei profichi, deponendo le uova nei fiori gallicoli e dando così origine alla seconda generazione di insetti, i
quali, dopo circa due mesi, uscendo e caricandosi di polline, entrano nei forniti e li fecondano, facendoli maturare.
Anche i frutt
i del fico domestico si evolvono e vengono fecondati dalle femmine dei pronubi, ma, avendo soltanto fiori